Pietro De Lucia
La gioia nella croce
Viaggio nel pensiero di Von Balthasar
EFFATÀ EDITRICE, 2021.
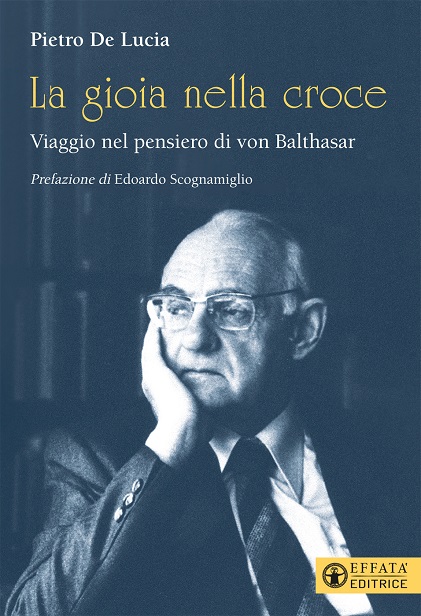 Davvero un bel libro questo saggio di De Lucia su Von Balthasar, dal titolo emblematico: La gioia nella croce , viaggio nel pensiero di Von Balthasar, EFFATÀ EDITRICE, 2021. Soprattutto per il semplice motivo che in meno di 200 pagine, con stile sobrio, conciso e puntuale descrive, nei più profondi dettagli, il percorso teologico spirituale del teologo svizzero. L’opera consta di tre capitoli dei quali il terzo è indubbiamente il fine cui tende l’Autore, il telos e lo sforzo della sua ricerca, come egli stesso riconosce quando, già nell’Introduzione dice: «nel terzo capitolo, cuore della mia ricerca, ho cercato di far emergere il pensiero di Balthasar circa la vera gioia»1. Scopo del lavoro, come chiaramente si legge in cifra nel titolo stesso, ha come obiettivo il far emergere il trabocchevole amore pieno di gioia del Figlio di Dio Gesù Cristo, proprio attraverso lo scandalo e la follia della croce. Questo movimento del Figlio di Dio verso di noi comporta una libera risposta che è anch’essa un movimento di ritorno gioioso verso la stessa radice di questa gioia; movimento anch’esso sfolgorante di gioia. «Se la nostra gioia è “posta” tutta in Dio ci porterà fino al punto di amare il sacrificio e allora questa gioia non sarà più psicologia e sperimentale, congiungente ed accidentale, ma diventerà ontologica, trascendente e divinizzante»2.
Davvero un bel libro questo saggio di De Lucia su Von Balthasar, dal titolo emblematico: La gioia nella croce , viaggio nel pensiero di Von Balthasar, EFFATÀ EDITRICE, 2021. Soprattutto per il semplice motivo che in meno di 200 pagine, con stile sobrio, conciso e puntuale descrive, nei più profondi dettagli, il percorso teologico spirituale del teologo svizzero. L’opera consta di tre capitoli dei quali il terzo è indubbiamente il fine cui tende l’Autore, il telos e lo sforzo della sua ricerca, come egli stesso riconosce quando, già nell’Introduzione dice: «nel terzo capitolo, cuore della mia ricerca, ho cercato di far emergere il pensiero di Balthasar circa la vera gioia»1. Scopo del lavoro, come chiaramente si legge in cifra nel titolo stesso, ha come obiettivo il far emergere il trabocchevole amore pieno di gioia del Figlio di Dio Gesù Cristo, proprio attraverso lo scandalo e la follia della croce. Questo movimento del Figlio di Dio verso di noi comporta una libera risposta che è anch’essa un movimento di ritorno gioioso verso la stessa radice di questa gioia; movimento anch’esso sfolgorante di gioia. «Se la nostra gioia è “posta” tutta in Dio ci porterà fino al punto di amare il sacrificio e allora questa gioia non sarà più psicologia e sperimentale, congiungente ed accidentale, ma diventerà ontologica, trascendente e divinizzante»2.
La teologia di Von Balthasar è indubbiamente una teologia della croce e lo è in quanto ha come momento centrale l’evento- Cristo, ossia la figura di un Dio umiliato e sofferente che, però, va subito detto, diventa nel Nostro la vera fonte della gioia, ovvero della beatitudo. La sua Estetica teologica muove da Dio stesso e la natura estetica della rivelazione sta nell’assumere forma, nel fatto che Dio stesso si autoesibisce nello splendore evidente che è Cristo. Emerge un primato dell’agire divino che è una vera e propria controrivoluzione teologica, intesa come rifiuto dell’imperante antropologismo e antropomorfismo teologico; è difatti l’uomo ad adeguarsi alla rivelazione e non viceversa. Da qui la ripresa dei trascendentali, intesi come proprietà dell’ens creatum e non come qualità del soggetto trascendentale kantianamente inteso, declinati nel pulchrum quale epifania del divino. Infatti, in Balthasar non è il cogito, inteso come autonomia coscienziale e chiusura in se medesimi, l’asserto originario dello spirito, quanto l’aperura estatica, l’esperienza della dipendenza rispetto a qualcosa che ci sovrasta e che viene prima di noi. Insomma, Balthasar con il suo lavoro teologico, ha voluto sbarrare la strada ad ogni tentazione atropocentrica, che facesse dell’uomo, e non di Dio, il cuore della teologia e il suo naturale punto di partenza.3 Infatti, nell’ambito proprio della rivelazione la Forma- Figura per eccellenza è rappresentata da Cristo, apparizione splendente, anche se velata nella carne, del mistero divino.4
I primi due capitoli del saggio di De Lucia hanno per oggetto una breve biografia teologica; mentre, il secondo esplicita il centro pulsante del pensiero teologico di Von Balthasar: lo stesso mistero pasquale, centrato in Cristo, splendore del Padre che, nell’evento della croce, rivela il suo stesso cuore divino. De Lucia coglie perfettamente nel suo lavoro la centralità di questo evento-cuore teologico della ricerca del Nostro.
Von Balthasar, definito da De Lucia, giustamente, per lungo tempo come una voce che grida nel deserto “disestetizzato” della nostra epoca5 per aver anticipato i tempi della trasformazione, operata dal Vaticano II e per averne poi colto buona parte della Wirkungsgeschichte; e, indubbiamente per il tempo necessario ad una assimilazione e comprensione del suo pensiero teologico. In questo capitolo il De Lucia coglie perfettamente lo spazio della ricerca di Von Balthasar quando dice: che il contesto teologico è fortemente segnato da due elementi: «da una parte, lo spostamento dell’asse di comprensione della rivelazione biblica operato dalla dottrina della giustificazione di Lutero e, dall’altra, il forte influsso del razionalismo moderno subito dalla teologia cattolica»6.
Tutto ciò indirizza la ricerca teologica del teologo svizzero verso il recupero dei trascendentali, tutti riletti a partire dal bello che, in quanto – direbbe Platone- verità che si fa vedere – è il luogo della teofania della luce in Dio, dunque il punto archimedeo della sua teologia che diviene una teologia della bellezza di Dio. È nel 7° paragrafo del I capitolo che diviene esplicita questa curvatura teologica von balthasariana. L’estetica teologica non è un addentellato della teologia ma il luogo stesso in cui si dà la rivelazione di Dio all’uomo e dunque della teologia come comprensione umana del mistero divino nella luce della grazia. «In realtà – ci dice l’Autore – non si dà percezione teologica fuori dalla luce della claritas, della grazia del lasciar vedere, la quale appartiene già oggettivamente al rapimento e soggettivamente introduce l’uomo in Dio»7. Ma è nel paragrafo successivo che emerge l’originalità del progetto del teologo svizzero. Infatti, il bello, il buono e il vero sono i trascendentali che sono a fondamento di una teologia tripartita in «teo-fanica, teo-prassica e teo-logica»8. A fondamento di questo progetto c’è il metodo fenomenologico così come Von Balthasar lo espone nella sua Estetica, dove emerge che «il bello non vive solo di splendore (Ganz) ma ha bisogno della forma (Gestalt) e dell’immagine (Bild)»9.
Nel capitolo II viene esposta la forma trinitaria dell’evento salvifico; e questo evento si presenta come “Mistero” e come “Dramma”. Come Mistero in quanto mistero pasquale, che «nella lunga riflessione di Balthasar, costituisce il centro di polarizzazione e di irradiazione di tutto il suo pensiero»10. In quanto dramma, l’evento salvifico «la Teo-drammatica è costruita sotto la simbolica del “teatro del mondo”» e, in quanto tale chiede la partecipazione dell’uomo all’evento stesso. Invito è appello e appello presuppone e invoca la libertà, libertà che «non è arbitrio (né in Dio né nell’uomo)»11, che nell’uomo da ragione aperta jaspersianamente intesa, diventa amore, in quanto risposta. Il sacrifico è la forma più estrema di questo movimento teo-drammatico, il cui esito è la risurrezione di Cristo e in Lui di tutta l’umanità. Va detto per inciso che questo «teo-dramma è innanzitutto mistero»12 e mistero d’amore sconfinato. Tutto ciò conduce al terzo elemento del trittico di Von Balthasar, quello appunto della teologia. Da tutto ciò emerge che la teologia di Von Balthasar è una «teologia della concretezza»,13 come suggerisce De Lucia.
Infine, il capitolo III, vero cuore pulsante del testo ci narra della gioia nella croce, croce che è il luogo stesso in cui la gioia si dà e si trasmette da Dio all’uomo, una gioia «del Padre nel Figlio attraverso lo Spirito Santo»14, come ci ricorda De Lucia. Da subito, infatti, emerge la novità della teologia trinitaria di Von Balthasar, rispetto a quella di Agostino e Tommaso, «i quali fondano la processione del Figlio sulla conoscenza e quella dello Spirito Santo sull’amore» laddove invece per il Nostro «il mistero della Trinità viene rivelato da Gesù Cristo e attraverso il Figlio possiamo affermare che Dio è amore»15.
Il mistero trinitario ha indubbiamente una epifania cristologica ma la novità di Von Balthasar è che questo centro cristico è anche intimo – e in modo misterioso – alla natura stessa trinitaria. Questo intimo movimento trinitario, movimento della gioia del dono ha una epifania in Cristo dono del Padre agli uomini16. Senza ombra di dubbio va chiarito che questa gioia è «inseparabile dalla croce»17; gioia che è beatitudine e che «non può essere descritta come un piacere sensibile o come un semplice sentimento del soggetto» e, dunque, avere un equivalente morale in senso filosofico che corrisponda a ciò18. Ed è nella croce che questa gioia trova la sua fonte e la sua ragion d’essere.
Massimiliano Mirto
1. Pietro De Lucia, La gioia nella croce viaggio nel pensiero di Von Balthasar, EFFATÀ EDITRICE, Cantalupa (To), 2021, p 19.
2. Ibidem, p. 19.
3. Giovanni Fornero, Balthasar, in Storia della Filosofia, vol. VII, pp. 390 – 416, GEE, Bergamo, 2006.
4. Ibidem, p. 400.
5. Cfr. Pietro De Lucia, La gioia nella croce viaggio nel pensiero di Von Balthasar, EFFATÀ EDITRICE, Cantalupa (To), 2021, p 23.
6. Ibidem, p.32.
7. Ibidem, p.43-44.
8. Ibidem, p.45.
9. Ibidem, p.51.
10. Pietro De Lucia, La gioia nella croce viaggio nel pensiero di Von Balthasar, EFFATÀ EDITRICE, Cantalupa (To), 2021, p 62.
11. Ibidem pp. 66 – 67.
12. Ibidem, p. 72.
13. Ibidem, p. 82.
14. Ibidem, p. 89.
15. Ibidem, p. 89.
16. Cfr. Pietro De Lucia, La gioia nella croce viaggio nel pensiero di Von Balthasar, EFFATÀ EDITRICE, Cantalupa (To), 2021, pp- 90 ss.
17. Ibidem, p. 94.
18. Cfr. Pietro De Lucia, La gioia nella croce viaggio nel pensiero di Von Balthasar, EFFATÀ EDITRICE, Cantalupa (To), 2021, pp- 98.
Plinio Perilli
Museo dell’Uomo, Poesie e poemetti 1994-2020
Editrice Zona 2020
 In questi ultimi decenni si è evidenziata l’importanza di rapporti interdisciplinari nelle varie materie. I lavori di letteratura e di critica ne hanno beneficiato arricchendo la vasta produzione nel campo della narrativa e della poesia. La silloge Museo dell’Uomo, Poesie e poemetti 1994-2020 di Plinio Perilli (2020 Editrice Zona) è espressione dell’orientamento della poesia del XXI secolo. La novità e l’attualità del volume è data dallo stesso autore per una poesia che fosse dinamica “in strenua ricerca, se non archeologica, emotiva delle nostre radici culturali, delle nostre vestigia profonde, ineludibili”. L’autore traccia e definisce l’attività e il pensiero dell’uomo dal presente al passato, in uno sviluppo temporale orizzontale ed anche verticale, se per quest’ultimo intendiamo la ricerca delle fonti e della ritualità profonde. La raccolta è ricca di argomenti articolati in diverse forme stilistiche che generano una dinamicità che s’accorda con i temi dominanti. Tuttavia, la preferenza per il verso libero gli permette di spaziare senza restrizioni nello sviluppo del pensiero e ad andare oltre. La sua è una poesia che è espressione di sintesi culturale in quanto si avvale di contributi della mitologia, archeologia, antropologia, storia, pittura, scultura, architettura, e di personaggi e uomini del presente e del passato, di accadimenti che furono di ieri ed eventi della società di oggi, senza mai perdere di vista l’ancestrale spiritualità che pervade l’intera raccolta. Perilli si muove fisiologicamente nell’interno delle sue liriche nel tracciare paesaggi e situazioni, nel vasto panorama museale di civiltà e di cultura dove protagonista è l’uomo e lo stesso poeta.
In questi ultimi decenni si è evidenziata l’importanza di rapporti interdisciplinari nelle varie materie. I lavori di letteratura e di critica ne hanno beneficiato arricchendo la vasta produzione nel campo della narrativa e della poesia. La silloge Museo dell’Uomo, Poesie e poemetti 1994-2020 di Plinio Perilli (2020 Editrice Zona) è espressione dell’orientamento della poesia del XXI secolo. La novità e l’attualità del volume è data dallo stesso autore per una poesia che fosse dinamica “in strenua ricerca, se non archeologica, emotiva delle nostre radici culturali, delle nostre vestigia profonde, ineludibili”. L’autore traccia e definisce l’attività e il pensiero dell’uomo dal presente al passato, in uno sviluppo temporale orizzontale ed anche verticale, se per quest’ultimo intendiamo la ricerca delle fonti e della ritualità profonde. La raccolta è ricca di argomenti articolati in diverse forme stilistiche che generano una dinamicità che s’accorda con i temi dominanti. Tuttavia, la preferenza per il verso libero gli permette di spaziare senza restrizioni nello sviluppo del pensiero e ad andare oltre. La sua è una poesia che è espressione di sintesi culturale in quanto si avvale di contributi della mitologia, archeologia, antropologia, storia, pittura, scultura, architettura, e di personaggi e uomini del presente e del passato, di accadimenti che furono di ieri ed eventi della società di oggi, senza mai perdere di vista l’ancestrale spiritualità che pervade l’intera raccolta. Perilli si muove fisiologicamente nell’interno delle sue liriche nel tracciare paesaggi e situazioni, nel vasto panorama museale di civiltà e di cultura dove protagonista è l’uomo e lo stesso poeta.
Il Museo è vivo, globale ed inclusivo, è pieno di vita e di emozioni, di ricordi che coprono un ruolo fondamentale perché fanno continuare a vivere tutto ciò che altrimenti cadrebbe nell’oblio. Ricca di afflato è la poesia dedicata al padre, Padre rinatomi, dove morte e vita tracciano una progressione generazionale volta al futuro:
“Troppo aspre guerre s’incarna, fiorisce la tua
pace, primavera di cento inverni, gelo a stille
– se del tuo nudo autunno s’ammanta la mia estate”.
Le poesie diventano terreni fertili dove si concretizzano altre possibilità formali e nuove immagini. I versi sono strumenti che valicano i confini territoriali e temporali, è non è dove il poeta registra la mutazione di valori e la natura della tradizione che è la memoria di ciò che l’uomo era ed è divenuto oggi. Quindi una visione della nostra identità, ma soprattutto la definizione di se stesso e della sua missione poetica.
A supporto di quanto affermato per la poesia di Plinio Perilli, è opportuno considerare l’attività del Mitomodernismo. Già il volume La parola innamorata, a cura di Giancarlo Pontiggia e Ernesto di Mauro, raccoglie liriche dove la parola è gestualità e suono, il linguaggio diventa antropologico ed i poeti sono contraddistinti da una forte componente linguistica. In I poeti italiani del Novecento, a cura di Stefano Giovinardi, si evidenzia la predilezione per mitologie estranee alla cultura cristiana, a partire dalla rivisitazione del patrimonio classico. Opere di diffusione, orientamento e creatività del XXI secolo sono Gli Argonauti. Eretici della poesia per il XXI secolo, antologia curata da Gabriella Galzio, e Le acque di Ermes, rivista curata da Massimo Maggiari. Presenza incisiva per il Mitomodernismo è il poeta Giuseppe Conte. Inoltre, sillogi quali Lo specchio di Dionisio di Angelo Tonelli, Aurora Borealis di Massimo Maggiari e Apocalisse Fredda di Gabriella Galzio, solo per citarne alcune, appartengono allo stesso movimento. Con ciò si vuole mettere in evidenza il concetto di globalità poetica, i poeti sono fautori del superamento territoriale, culturale e temporale. A ciò possiamo aggiungere la corrente del Ritomodernismo ideata da Tonelli che colloca il poeta nella tradizione “di un’avanguardia datata duemilacinquecento anni avanti Cristo e più di duemila dopo”.
A questo contesto, degli orientamenti della poesia del nostro secolo, appartiene il lavoro di Perilli. Il Museo è un luogo rituale dove il gesto e la parola hanno un potere evocativo. “Kuska” è il titolo della lirica ed il nome di una cagnetta. La qualità sonora della parola trascende la concretezza dell’immagine e rimanda ad altra sensazione quasi “umana e tremante” dove “solo la lingua sopravvive radiosa, intelligente dell’armonia/ di ogni sillaba”.
Indicativo, come già affermato, è il titolo di questa raccolta che comprende lavori che vanno dal 1994 al 2020, sebbene il mestiere di poeta fosse iniziato negli anni Ottanta. In essi sono registrati i momenti che hanno dato vita all’ispirazione contestualizzandoli nel tempo e fissandoli nella mente. È vero che la mission di Plinio è quella di dare voce alla sua ricerca delle radici culturali sia antropologiche che emotive, ma aggiungerei soprattutto spirituali.
Significativa ad apertura della raccolta è Adamo disteso, che dà anche il titolo ai versi pervasi da un profondo sentire religioso, la creazione dell’uomo dalla mano di un Dio artista:
“Prego perciò la mano e il respiro di Dio
di scolpirmi forte dentro il cuore,
soffiarmi l’anima”.
Riferimento alla scultura di Giacomo Manzù, Adamo Disteso, è riportato dallo stesso poeta che cita Livia Velani la quale, nella La Raccolta Manzù, Ardea 1994, riporta la difficoltà che lo stesso scultore ha avuto nell’idearlo e di John Houston nel renderlo visivo nel film La Bibbia: la nascita di Adamo, la vita che prende forma da un sasso per poi svilupparsi nel corpo di un uomo.
Plinio rivive la nascita e la rinascita di Adamo attraverso l’arte, che riafferma il legame fra la vita e il suo creatore, il quale “incorona” l’Uomo “re della Natura”. Il lettore avverte un’identificazione nel processo della creazione del primo uomo quando la sua mano di scrittore affonda nelle corde più profonde dell’amore verso Dio. L’Adamo disteso pone il lettore di fronte alla ricchezza di questa poesia dalla quale scaturisce la rinnovata meraviglia del poeta di fronte al creato dove la grandezza di Dio si manifesta attraverso uno specchio:
“Oggi tu artista
mi scolpisci – ne sogni vera l’immagine –
sappi che io nasco, pulso e rinasco ancora
come quel primo giorno, stupefatto al miracolo,
di fare specchio a un Dio per trasparenza
d’amore…”.
“… nessun scultore, soltanto Dio
sa plasmare….
Nulla ero
nel primo ma tutto era già stato, come parola
riassumo il gesto, il pensiero, la carezza che un Padre
ama fare al figlio: ed io proprio da questo sono nato” (da Adamo disteso).
La mente si espande in un universo di stampo barocco:
“L’infinito non ha fine eppure
si ripete sempre identico.
Il mio mondo universo
ne è infiniti altri, infinitesimi, limitati all’illimite
sconfinato, estenuato di Dio -…” (da Stella Cuore).
In questi versi sentiamo la voce di Giordano Bruno che dice dei “suoi ultimi attimi/ Infiammati/ da terra a cielo…”. L’intensità della mente “come unico fine/ha l’infinità” (da Stella Cuore).
Lo sbigottimento che potrebbe generare viene affrontato da Plinio con la preghiera e la speranza, “Dentro l’uomo è la luce” e “l’amore che all’amore parla in silenzio” (da Dentro l’uomo è la luce).
Grazia Sotis
Loyola University Chicago
Giuliano Zanchi
La bellezza complice. Cosmesi come forma del mondo
Vita & Pensiero, 2020
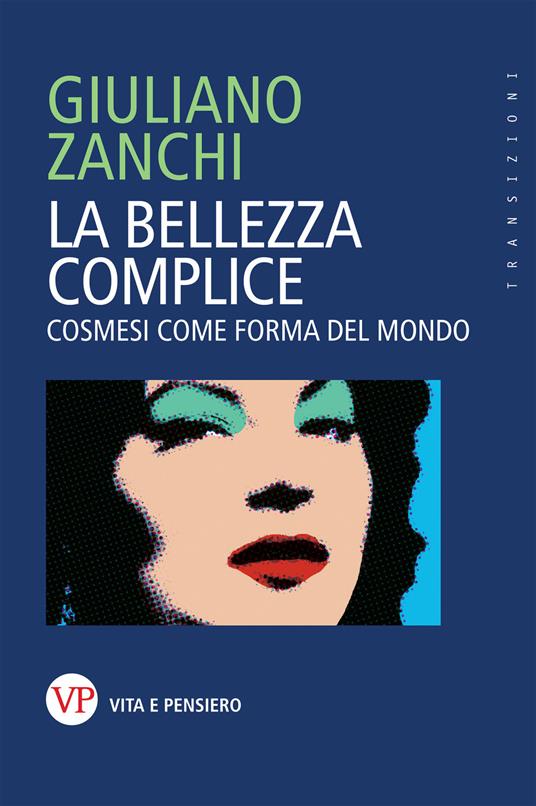 Cos’è la bellezza nella nostra civiltà e come viene vissuta? A questa domanda cerca di rispondere Giuliano Zanchi, autore del saggio La bellezza complice. Cosmesi come forma del mondo, edito da Vita & Pensiero nel 2020. La bellezza si identifica con la dimensione estetica, che avvolge e orienta le nostre vite, senza avere più alcun nesso con la ricerca della verità. La bellezza si manifesta nella seduzione, come vera e propria smania di colpire e di piacere, che ha invaso tutti i campi, da quello sociale, all’ambito della vita economica, politica, pedagogica e, senza mostrare alcuno sfondo, emerge come estetizzazione diffusa collegata ad una radicale cultura dell’immanenza. Nella nostra civiltà, l’occupazione primaria è quella della cura della forma, e pur nella diversità dei gusti, la bellezza appare presente ovunque come dominio dell’estetica. Nata come scienza della conoscenza sensibile e divenuta con Kant filosofia dell’arte, la dimensione estetica mira alla rappresentazione del mondo e non alla realtà in quanto tale.
Cos’è la bellezza nella nostra civiltà e come viene vissuta? A questa domanda cerca di rispondere Giuliano Zanchi, autore del saggio La bellezza complice. Cosmesi come forma del mondo, edito da Vita & Pensiero nel 2020. La bellezza si identifica con la dimensione estetica, che avvolge e orienta le nostre vite, senza avere più alcun nesso con la ricerca della verità. La bellezza si manifesta nella seduzione, come vera e propria smania di colpire e di piacere, che ha invaso tutti i campi, da quello sociale, all’ambito della vita economica, politica, pedagogica e, senza mostrare alcuno sfondo, emerge come estetizzazione diffusa collegata ad una radicale cultura dell’immanenza. Nella nostra civiltà, l’occupazione primaria è quella della cura della forma, e pur nella diversità dei gusti, la bellezza appare presente ovunque come dominio dell’estetica. Nata come scienza della conoscenza sensibile e divenuta con Kant filosofia dell’arte, la dimensione estetica mira alla rappresentazione del mondo e non alla realtà in quanto tale.
Le rappresentazioni culturali del mondo e le simbolizzazioni immaginifiche sono finalizzate a conferire una forma, a qualificare un apparire, che a lungo andare, finiscono per riguardare la realtà stessa. I fattori cosmetici, oggi, mediano la costruzione del soggetto postmoderno, affinché esso possa essere ciò che desidera, in una miscela di trasformazioni del sé finalizzate al cambiamento e contemporaneamente al mantenimento della propria identità. Si muta per rimanere se stessi e lo si fa esplorando ogni territorio del possibile per cercarsi anche nel tutt’altro. Per raggiungere questo fine, ci si deve necessariamente sottoporre ai giudizi delle idealizzazioni del sé che la cosmetica deve soddisfare. E questo avviene attraverso il mercato delle merci che induce a volere ciò che vogliono gli altri e a ricercare proprio ciò che è voluto da altri. Nella convinzione di essere singolari si finisce per essere portatori di conformità. Se «la verità è brutta e l’arte è stata data agli uomini per non perire a causa della verità», come aveva affermato Nietzsche nel 1888, allora viene scardinato il fondamento ultimo della realtà di tradizione umanistica e cristiana che collegava insieme bellezza, verità e bontà. Tolto il vecchio mondo dei valori considerato un’illusione, resta solo la verità della solitudine e dell’inconsistenza degli uomini che appaiono pura aggregazione materica che viaggia verso il nulla. Per sopravvivere a una verità così tremenda, essendo esposti alla completa inconsistenza del tutto, solo la capacità di ricrearci come potenze volenti può dare un senso a quella tragedia che continua a restare la condizione umana. L’arte, dunque, è quella qualità propria dell’essere umano che consiste nel doversi sempre cercare nella forma della volontà.
Con Nietzsche il mondo soprasensibile di matrice platonica viene abolito e resta il mondo sensibile che però non è più il riflesso di una sostanza che sta altrove, ma è sola materia la quale, proprio perché insussistente, deve sempre essere plasmata. L’essere umano, per non perire a causa della verità, può solo incanalare le proprie energie nella plasmazione di una forma per volere sé stesso (la volontà di potenza che è all’origine dell’arte). Nella trasvalutazione di tutti i valori, sembra indispensabile la condizione estetica come dimensione di fondo della realtà che non può essere senza doversi creare. La volontà di potenza come arte diventa l’idea di fondo di un intero sistema sociale. Tra le grandi personalità che hanno contribuito alla nascita del nuovo mondo vanno annoverati Beethoven, Dostoevskij, Stirner, Cioran, Pedro Calderon de la Barca, Arthur Schnitzler, ma soprattutto Wagner e Schopenhauer. Attraverso questi due ultimi pensatori vengono poste le basi per una realtà e una vita dell’uomo intesa come un’immensa opera d’arte, da modellare con la volontà. L’uomo finisce per costruirsi sfere di immunità di fronte alla patogena esposizione al nulla e progredisce in questa sua professione di designer dell’essere cosciente di quello che fa. Gli esseri umani hanno eliminato il trascendente ma poi hanno finito per costruirsi altre dimore del senso. Sono loro ad esserne i costruttori mediante l’autoproduzione estetica. Finito il tempo dei teologi ora si fa spazio l’opera dei designers dell’essere, secondo i quali il mondo non si realizza più adeguandolo alla sua verità trascendente, bensì lo si costruisce a rimedio della vanità immanente. Il mondo è un immenso atelier in cui gli esseri umani sono impegnati nella costruzione dei loro set del momento. Così l’arte non è più luogo di rivelazione dello Spirito, ma riflesso della nuova religione, quella della dimensione economica.
Vi è una spiritualizzazione che è presente ma è senza dio tanto nel fenomeno artistico quanto nelle manifestazioni religiose, nel capitalismo, quel fenomeno sociale totale che si era assunto il compito di rispondere alle inquietudini e alle aspettative umane, che in passato era stato la fondamentale preoccupazione delle religioni storiche. I grandi centri commerciali sono l’immagine del gigantesco investimento simbolico estetizzato e sacralizzante, che si concretizza nell’incontro tra l’individuo e l’offerta dei prodotti. Il comprare tocca la sfera del desiderio diventando una vera e propria esperienza dello spirito, alla ricerca della felicità. Gli outlet si presentano come luoghi per culti estetici che hanno finito per sostituire i luoghi di pellegrinaggio verso santuari. Con la morte dei grandi valori metafisici, il desiderio va verso il godimento di oggetti del bisogno (merci), considerati come potenti veicoli del desiderio (senso), sebbene questo si spenga nell’oggetto che si ottiene e che quindi richiede nuovi desideri verso nuovi oggetti, e questo rende vivo il mercato. Il consumo, quando è vissuto come una risposta al desiderio, ha bisogno dell’ancora e del sempre più. La strutturazione della civiltà su base capitalistica e la generalizzata estetizzazione della vita sociale formano due componenti complementari e intensamente interconnesse. Tutto, nella nostra civiltà, è costruito intorno ad un apparato estetico: la vita religiosa, lo sport, il sesso, la morte, l’economia, la costruzione del sé, l’immaginazione. In mancanza di orientamenti certi e condivisi, anche la condizione umana si realizza nella scelta di vita, come esperimento del bricolage del sé da rendere visibile necessariamente. Si esiste nella misura in cui si è in grado di essere visibile e a questo scopo agisce la dimensione estetica che confeziona ogni elemento necessario con le sue industrie. L’estetica, insomma, si presenta nel nostro tempo come nuovo domicilio del religioso in tutti i fenomeni portanti della nostra civiltà: capitalismo, consumo, arte, sport, scienza. Ed è proprio qui che agisce e che deve essere intercettata la forza della qualità sensibile del rapporto tra gli umani e la realtà.
Roberta Foresta
Laura Corraducci
Il passo dell’obbedienza
Moretti & Vitali, luglio 2020
 L’autrice, Laura Corraducci, ne Il passo dell’obbedienza, edito da Moretti & Vitali nel mese di luglio 2020, sceglie la parola poetica per tracciare il percorso dell’esistenza umana, che, nel viaggio della vita, è celebrata attraverso l’esperienza dell’amore, del male, della presenza sublime della natura, del divino. Il viaggio è descritto come attraversamento di più confini, spesso evocati ricorrendo a metafore che richiamano quelle bibliche.
L’autrice, Laura Corraducci, ne Il passo dell’obbedienza, edito da Moretti & Vitali nel mese di luglio 2020, sceglie la parola poetica per tracciare il percorso dell’esistenza umana, che, nel viaggio della vita, è celebrata attraverso l’esperienza dell’amore, del male, della presenza sublime della natura, del divino. Il viaggio è descritto come attraversamento di più confini, spesso evocati ricorrendo a metafore che richiamano quelle bibliche.
Così, il confine è evocato attraverso la duplicità di senso di luce e buio, gioia e dolore, bene e male. I versi conducono il lettore al tempo autunnale, quando l’uva matura e la luce del sole crea un gioco di colori nell’acqua del fiume, lì dove «il cielo si è finalmente piegato», quasi un’eco della voce del salmista che invoca il Signore: «Piega il tuo cielo e scendi» (Sal 143,5). Lì, dove l’erba è incolta e dimenticata, terreno arido, metafora del deserto della vita, è possibile vedere la tenda dimorare nel deserto, simbolo della presenza di Dio e del mistero dell’incarnazione («E il Verbo si fece carne e pose la sua tenda tra di noi» Gv 1,14). La tenda è anche figura dell’amore, che con le sue mani fa «scudo dai fulmini», nonostante vi siano segni di morte sul corpo scheletrico, quelle mani che nell’amore spezzano i confini, attraversandoli.
La vita va vissuta nell’obbedienza alle gioie che la vita riserva, all’amore, ma anche ai momenti di dolore.
Come possono essere gli eventi dolorosi della vita che fanno entrare in noi il gelo, come nelle «sere d’inverno», dove, nonostante la solitudine e la mancanza dell’amato, non viene meno la speranza, l’attesa paziente di chi spera appunto di poter rinascere e ritrovare la libertà, paragonata ad una vela che «nei giorni di vento» dirige la nave verso la sua meta.
Il rovescio della luce appare nella vita del giovane seminarista Rolando Rivi, in quella sua morte atroce avvenuta nell’aprile del 1945, che l’autrice vede nel suo disvelare un senso più alto, l’essere «corona di spighe sul mondo» – come non pensare al «Noi siamo frumento di Dio» di Ignazio di Antiochia pronunciato poco prima del suo martirio -? Ma «quella giovinezza svanita dalle mani», quel sacrificio della sua vita può ancora dire qualcosa agli uomini, attraverso «una lingua di sillabe nuove». Anche «il pianto della madre che prega» è allo stesso modo una parola di senso agli uomini nel viaggio della vita. Il pianto di una madre, il suo dolore, può trafiggere il cielo ed arrivare a Dio.
«Bisogna attraversarlo» nell’obbedienza il proprio destino, come si attraversa «un ponte interrotto sul confine»: tutto, le voci e i ricordi delle persone amate, custodite nel ventre che si dilata, allo stesso modo del ventre di una donna gravida, sembra compiersi per una necessità superiore.
Nonostante tutto, o proprio attraverso tutte le vicende belle e brutte che accadono, la vita arriva al suo compimento «insieme al dolore bagnato di un fiore nel passo danzante dell’obbedienza». Paragonata ad una danza, la vita è bella e fragile come un fiore. Il richiamo a Dante, al «nome del bel fior ch’io sempre invoco» (Paradiso XXIII), unisce la bellezza della vita all’invocazione al fiore più bello, il Dio-con-noi, che nei versi poetici dell’autrice si fa presenza tra gli uomini «nel silenzio garbato e greve degli occhi / in un tondo perfetto di luna di marzo …».
La lettura di questo testo poetico trasmette un senso profondo di umanità, infonde speranza proprio nel suo attraversare con la poesia i tanti confini dell’esistenza, verso la luce, verso un’obbedienza più alta.
Roberta Foresta
Maria Rita Bozzetti
DIALOGO CON TERESA
Libreria Editrice Vaticana,
Città del Vaticano, 2021, pp.233, 30.00 euro

Due donne, di età e condizione sociale e storica diverse, una di fronte all’altra e in dialogo: è questa la situazione di questo libro singolare e affascinante che vede sinotticamente giustapposte le loro scritture in un serrato corpo a corpo di verità.
La prima è Teresa di Lisieux, monaca carmelitana francese, morta di tubercolosi giovanissima, a soli 24 anni, nel 1897, al termine di una vita vissuta con incandescente passione mistica, e proclamata Dottore della Chiesa, terza donna a ricevere tale riconoscimento, nel 1997.
La seconda, l’autrice del Dialogo, Maria Rita Bozzetti, è una donna di oggi, “immersa nella vita” quanto basta per sentirsi “impegnata” e compresa nei problemi del sociale eppure sempre intenta con severa determinazione ad “esplorare il proprio petto”, per dirla con Leopardi, accanto e a ridosso della sofferenza altrui, sempre chiedendo e trovando nella poesia, propria e altrui, un sollievo e un aiuto, la chiave d’oro alla risoluzione dei propri più intimi travagli.
Ad accomunare le loro storie, almeno tre cose, che si intravedono dalla vita e affiorano dagli scritti di entrambe.
Innanzi tutto, il dolore: Teresa, con un suo personale calvario di sofferenza, gioiosamente accettato, destinato a consumarla giovanissima, non senza aver prima lasciato una testimonianza preziosissima della peculiarità del suo percorso spirituale attraverso un gran numero di opere (poesie, opere teatrali, lettere e scritti autobiografici in cui condensare ricordi e riflessioni della sua breve vita), sull’asse dolore-amore; Maria Rita, con un’analoga esperienza, che, sulla scorta di libri e figure fondanti (il Vangelo di Giovanni, Qohèlet, il suo Maestro, Nicola De Donno) e ora anche di Teresa e della lettura della sua Storia di un’anima, ha visto trasformarsi progressivamente la sua esistenza ed ha accettato di raccontarsi. Entrambe insomma trasformando la concretezza del proprio avvertimento in esercizio e sperimentazione di sé, nella sete di conoscersi scrivendosi, pura “sete d’amore” (Maria Rita esplicitamente la evocava già in un testo della raccolta Sul retro di cuori e Teresa la invoca come desiderio di “amare sino a morire d’amore”, c.281).
Assieme al dolore, un’ansia di trascendente e di assoluto, un’esigenza di ascesi, che si realizza attraverso un esercizio di scomparsa e spoliazione di sé, per proiettarsi totalmente, “al divino dall’umano / all’etterno dal tempo”, direbbe Dante (Paradiso, XXXI, 37-38), in ciò che fonda pensiero e realtà al di là delle esistenze individuali, cioè Dio, l’Absconditus, verso cui agostinianamente si protende il cor inquietum di ogni creatura: Maria Rita, la vive al di là del contingente e dell’empirico come graduale e continua scoperta e necessità, come prezioso strumento di autodisciplina e sguardo a specchio su di sé e sul mondo, non meno di Teresa, la sua spirituale Sorella di Lisieux, dalle cui parole, nei 100 capitoletti che costituiscono il Diario, prende autorizzazione e abbrivio passo dopo passo la sua ricerca. Come chiamarla altrimenti questa esigenza se non col termine paolino di “caritas”, di Amore, che ritorna nelle parole di entrambe come un contrappunto costante di pensieri e sentimenti e in cui si rispecchiano e sublimano come in aenigmate tutte le cose e le circostanze della vita?
E in più una fede nella scrittura, in un ostinato scri/vi/versi, che, qui più che mai, tra la Storia di un’Anima della mistica francese e il Dialogo con Teresa di Maria Rita, non si fa fatica a far risalire a quello che è l’autentico archetipo del genere, ossia le Confessioni di Agostino, l’esperienza che ha fondato uno spazio nuovo tra il soggetto e la sua interiorità, il suo “cuore”, nel senso assegnato a una rappresentazione di sé, al genere autobiografico, come ricerca di significato, ancor prima che come esperienza letteraria e formale: come percorso insomma che si interroga sull’Io e sul suo destino dell’essere nel mondo, in una proiezione governata dallo sforzo continuo di leggere gli eventi, oltre ogni retorica, come un esemplare processo di fatti misteriosamente concatenati tra loro secondo una loro storia interiore, una loro spirituale sintassi, che li fa significare nella loro proiezione al di là di ogni vicenda personale. Questo per dire che per entrambe, come avviene in ogni esperienza mistica, lo scriversi “cancella la personale voce”, come dice Maria Rita nel cap.100, per lasciare spazio solo al Verbo che le abita con la sua luce: entrano insomma in un’area in cui ogni “cammino”, in nome dell’Amore, perde la sua individualità, per vederle insieme protagoniste e spettatrici, paradigmi ed emblemi di una universalità di destini, proiettate come sono, “dall’infima lacuna dell’universo”, per dirla con Dante, verso il Cielo.
C’è insomma un legame forte e concreto, una spirituale sorellanza, che annoda esistenze ed esperienze al di là della letteratura, tra la Storia di un’anima di Teresa di Lisieux e la meditazione contenuta nel Dialogo con Teresa, in cui Maria Rita Bozzetti ha preso la parola dalla Santa per trasformarla in questo suo periplo avvolgente, soffermandosi su passaggi e immagini del libro, che decifrano il “racconto della vita intima” della mistica di Lisieux, non tanto per farne un commento quanto piuttosto per trovarvi un’occasione di “colloquio”, uno spunto di comunanza, con la sua stessa anima.
Il risultato è, per Maria Rita, un’immersione, una traversata addirittura in essa, attraverso la lettura delle sue pagine, che al di là della sua apparente chiarezza può risultare ardua e non facile da accettare, ma necessaria specie in tempore tristitiae, per capovolgere il comune modo di vedere le cose. A rischio di apparire agli occhi di noi lettori eccessivo e insieme povero: eccessivo, per l’investimento e la sommersione emotiva; povero, troppo povero, per la riconosciuta inadeguatezza al modello, eppure, a dispetto del codice, esegetico e parafrastico, entro cui è costretto, ambiziosamente proteso a vedersi testimone e paziente di un processo di personale riscatto, tanto da farle ammettere senza imbarazzo il suo debito impagabile verso lo scritto della giovane mistica (“Leggere Storia di un’anima mi ha cambiata: davvero mi sento ora diversa”, ha dichiarato).
Potere taumaturgico del Libro, dunque, che, come condensa e sublima una vita (la Storia di un’Anima), così può prefigurare e disegnare un destino, quello di Maria Rita, donna in “costante migrazione”, stando al titolo di una sua precedente raccolta, col suo inesausto bisogno di prospettive e risposte: due donne, due anime, si incontrano e dialogano sul filo di una parola che, come un filo d’Arianna attraversa e annoda le loro storie, diventando per entrambe occasione e esperienza di senso.
Questo perché ogni libro, quando è vero, quando è historia sui, storia del sé più autentico, è una storia di ordine ieratico che per forza di scrittura mette in scena un Evento che dà senso a tutto: che contagia e si trasmette al di là del tempo e in cui molti, tutti, possono vivere. Assieme e oltre alle ragioni più intime e private, disegna infatti un percorso che attiene, certo, alla memoria di chi scrive, cosciente della propria inadeguatezza a dirsi pienamente e perciò continua a scrivere, ma più ancora forse attiene al sentimento collettivo, che accomuna chi scrive a chi legge nel senso che affida a questi inconsapevolmente il testimone di un fuoco. Come di un bisogno in cui si incrocino respiro, preghiera e profezia: il bisogno di una novella Pentecoste, destinata a riaccendere lumen sensibus, per sé e per gli altri, come la liturgia auspica ed invoca; la necessità di instaurare un patto per il tramite del Libro, che chi legge, come il Veggente di Patmos, deve inghiottire per conoscerne il sapore di miele e amaro e risputarlo, iniziando a sua volta anche lui a profetizzare, ad annunciare “un cielo nuovo e una terra nuova”, come aveva annunciato Isaia.
Maria Rita Bozzetti che, nella sua storia di scrittrice, a partire dalle sue prime prove un trentennio addietro, non ha mai fatto mistero di volersi mettere sempre in gioco con un approccio autobiografico alla scrittura in direzione fortemente testimoniale, questo compito se l’è assunto, da sempre offrendo, eucaristicamente, sogni e pensieri come particole di sé, come “dono”, per invitare il lettore al suo spirituale banchetto di sapere, qui umilmente cedendo il passo alle parole di Teresa per lasciarle dire la forza dell’”amore che attira come un magnete” (cap.98) l’anima di entrambe.
È dentro siffatto meccanismo, che si inscrive Dialogo con Teresa di Maria Rita Bozzetti, nello spazio di una soggettività che si sente interpellata e al tempo stesso interpella, dialogando per il tramite della parola della Santa di Lisieux, per offrire a specchio la sua historia attraverso la scrittura a noi che ne scorriamo le pagine.
Uno spazio per i quale non si sa quale altra definizione più efficace utilizzare se non quella già adoperata dalla stessa Maria Rita Bozzetti con lucida pertinenza poetica nel congedo della sua raccolta I dintorni della tua memoria (2007) chiamandolo “urna di luce” (“e torna nell’urna di luce / dove il tempo si arricchisce del Sé”).
Ecco, è qui, in quest’”urna di luce”, che è avvenuto il miracolo della (sua) poesia. È qui che il “tempo” ha agito e si è arricchito ed è maturata l’esperienza di sé attraverso il “colloquio” con Teresa, sviluppandosi nel corso di non pochi anni, in un impegno silenzioso a ridosso della meditazione del racconto della vita intima della Santa, nel suo “dialogo con se stessa per spiegare le reazioni del cuore agli accadimenti”, che Maria Rita ha attraversato con simpatetica attenzione ai suoi passi, nel “resoconto quotidiano del rapporto con Dio, unico interlocutore del vivere” (cap.1).
“Su tutto governava il mio pensiero che sempre cercava di andare oltre, per trovare una sua dimensione vera”, ha ammesso in una confidenza privata e si capisce che davvero non si può non crederle: non si può non convenire completamente con ciò che solo lo spazio epistolare può consentire con altrettanta sincerità (e “semplicità”) fin dalle primissime battute di un testo che si potrebbe senza forzature definire amebeo, dialogico e bifronte, tra prosa e verso, inquadrandolo entro un genere antico dalle nobili ascendenze, quale il prosimetro, componimento letterario di argomento amoroso o filosofico non solo per la commistione delle parti, ma soprattutto per la felice modulazione dei toni, tra argomentazione, commento e abbandono lirico.
Vincenzo Guarracino
François Bœspflug ed Emanuela Fogliadini
Il Natale nell’arte
Jaca Book, pagg. 210
 Sono tanti i libri sulla iconografia della Natività. E tuttavia l’opera di François Bœspflug ed Emanuela Fogliadini (Il Natale nell’arte, Jaca Book, pagg. 210) apparsa più d’un anno fa, va riletta e segnalata, giacché al di là della suggestione immediata che il volume procura (grande formato, pregevoli illustrazioni, più di cinquanta immagini a tutta pagina, di cui sono approfonditi con cura scientifica e godibilità gli aspetti inografici e iconologici) un preciso progetto espositivo e documentario lo anima. Che muove dall’assunto che un discorso sulla Natività, pur per immagini, è in primis un discorso teologico, in particolare cristologico, e come tale va letto e attraversato. Sicché «una presentazione della Natività di Cristo comporta anche una ricostruzione dei dati storici che vi si legano e delle implicazioni in relazione alla chiesa nascente». Gli autori approfondiscono nella premessa la questione della attribuzione della data in cui Cristo è nato, anche nel confronto tra le chiese occidentali e quelle orientali. Invero «l’iconografia dei cristianesimi d’Oriente e d’Occidente è non solo il fil rouge del volume ma il luogo della manifestazione della teologia e del dogma, della creatività e vitalità artistica, della pietà». Gli autori chiariscono poi le scelte iconografiche di fondo. Si sono concentrati sulla Natività in senso stretto, senza contemplare altri temi, pure cari agli artisti, come l’adorazione dei pastori o la visita dei Magi. D’altro canto, essi affermano, si è voluto ampiamente approfondire la rappresentazione della natività nei primi secoli della Chiesa, senza ignorare alcune espressioni locali. Sicché il criterio privilegiato è in definitiva «il racconto del medesimo mistero attraverso le molteplici voci della teologia e della iconografia». Riguardo alla presentazione delle opere si apprezza particolarmente l’equilibrio tra descrizione e contestualizzazione storico- teologica e parallela lettura dell’immagine. Anche sotto questo profilo il volume appare pregevole, per la semplice intensità del suo linguaggio e per la rara capacità di fare entrare il lettore nell’opera, come in un viaggio a un tempo storico-critico e spirituale senza dilungarsi in personali considerazioni e tuttavia presupponendole, come una sensibile prospettiva di fondo.
Sono tanti i libri sulla iconografia della Natività. E tuttavia l’opera di François Bœspflug ed Emanuela Fogliadini (Il Natale nell’arte, Jaca Book, pagg. 210) apparsa più d’un anno fa, va riletta e segnalata, giacché al di là della suggestione immediata che il volume procura (grande formato, pregevoli illustrazioni, più di cinquanta immagini a tutta pagina, di cui sono approfonditi con cura scientifica e godibilità gli aspetti inografici e iconologici) un preciso progetto espositivo e documentario lo anima. Che muove dall’assunto che un discorso sulla Natività, pur per immagini, è in primis un discorso teologico, in particolare cristologico, e come tale va letto e attraversato. Sicché «una presentazione della Natività di Cristo comporta anche una ricostruzione dei dati storici che vi si legano e delle implicazioni in relazione alla chiesa nascente». Gli autori approfondiscono nella premessa la questione della attribuzione della data in cui Cristo è nato, anche nel confronto tra le chiese occidentali e quelle orientali. Invero «l’iconografia dei cristianesimi d’Oriente e d’Occidente è non solo il fil rouge del volume ma il luogo della manifestazione della teologia e del dogma, della creatività e vitalità artistica, della pietà». Gli autori chiariscono poi le scelte iconografiche di fondo. Si sono concentrati sulla Natività in senso stretto, senza contemplare altri temi, pure cari agli artisti, come l’adorazione dei pastori o la visita dei Magi. D’altro canto, essi affermano, si è voluto ampiamente approfondire la rappresentazione della natività nei primi secoli della Chiesa, senza ignorare alcune espressioni locali. Sicché il criterio privilegiato è in definitiva «il racconto del medesimo mistero attraverso le molteplici voci della teologia e della iconografia». Riguardo alla presentazione delle opere si apprezza particolarmente l’equilibrio tra descrizione e contestualizzazione storico- teologica e parallela lettura dell’immagine. Anche sotto questo profilo il volume appare pregevole, per la semplice intensità del suo linguaggio e per la rara capacità di fare entrare il lettore nell’opera, come in un viaggio a un tempo storico-critico e spirituale senza dilungarsi in personali considerazioni e tuttavia presupponendole, come una sensibile prospettiva di fondo.

